di Ilaria Patti
Opinione breve (non richiesta) sul dibattito Armine, la ragazza armena apparsa sulla passerella della collezione Primavera/Estate 2020 di Gucci, che si è trovata negli ultimi giorni nel bel mezzo dell’occhio del ciclone mediatico: spoiler, non ci interessa granché.
Innanzitutto, non ci interessa assolutamente prendere parte alla triste e noiosa diatriba semplificata all’osso che scade al livello del bella/brutta, perché le legioni di guerra hanno già combattuto abbastanza.
Da un lato, le amazzoni del buonismo che vogliono Armine per forza bella (come se la bruttezza fosse qualcosa da demonizzare come la peste nera e la bellezza l’unico canone utile per definire una donna) e che, come cavalli da tiro privi di senso critico, si sono bevute alla goccia la retorica della rivoluzione dei canoni estetici; dall’altro, i soliti biechi leoni e leonesse da tastiera masterizzati presso l’università del livore che non vedono l’ora di poter tuonare crudelmente (come crudele è stata la campagna) contro la bruttezza di Armine, dimostrando di essere rimasti ancorati a linguaggi vecchi di trent’anni e di non capire nulla di contemporaneo (belli loro, poi).

Il motivo per cui non è interessante questa diatriba è la sensazione che Gucci volesse ottenere esattamente questo: far entrare un gladiatore nell’arena, liberare le bestie affamate e godersi lo spettacolo dalla tribuna dalla quale esprimere il giudizio finale con il pollice alzato o abbassato.
Non ci interessa la profusione di retorica sulla parola più gettonata del momento, cd body shaming, ovviamente non perché il tema sia irrilevante o perché in questo caso non c’entrasse, quanto perché è stato mal individuato il soggetto attivo che l’ha commesso.
Il body shaming non lo fa la massa: il gregge di pecore non è strategico, segue le orme del pastore.
Chi comunica conosce perfettamente le regole per diventare virale: ha semplicemente preso questa ragazza, l’ha infilzata con un amo e gettata nella vasca del piragna, ben conscio della violenza che avrebbe generato, al solo scopo di far parlar di sé.
Temo che il fine ultimo di Gucci non sia cercare di rivoluzionare l’idea di bellezza, ma dare in pasto una ragazza alla rete per sfruttare gli insulti che generano attenzione sul brand e crescita di popolarità.
Se, come ha scritto qualche romantico naif, la donna è stata liberata dall’essere oggetto dei sogni erotici maschili, mi sembra che sia passata all’essere oggetto di un marketing spietato, calcolatore, ipocrita.

Non ci interessa la trita enfasi dell’arte come provocazione, spaccatura della tradizione per creare un nuovo concetto di bello. Non è interessante fatta così, perché francamente non vedo alcuna urgenza creativa o genuina innovazione, ma solo una risposta al mercato attraverso la ricerca di qualcosa di ormai banale da selezionare e celebrare all’occorrenza: il grottesco, il disturbante, il fuori canone.
La stessa sensazione di non autenticità e di forzatura estrema del concetto appariva, ad esempio, con la scelta di puro marketing di un cantante come Achille Lauro da esibire all’interno della cornice più conservatrice della cultura televisiva italiana, con una performance molto più incentrata sul creare un discutibile chiacchiericcio e sul dividere l’opinione pubblica, piuttosto che sul portare qualcosa di interessante artisticamente in termini di contenuti e di musica (ma so che è una unpopular opinion perché i più l’avevano trovata un’irriverente provocazione al noioso senso del pudore borghese, che avrebbe liberato l’artista dall’obbligo di inchinarsi alle convenzioni sociali del passato – de gustibus. Per altro Achille Lauro mi piace, come mi piace Armine, ma trovo che non sia questo il punto).
Quello che pare così evidente da risultare quasi un’ovvietà, è che si tratta indubbiamente di una strategia commerciale pienamente riuscita, purtroppo però a spese di Armine.
Questa eccessiva forzatura del messaggio, così didascalico, così spot, così mediatico, l’ha svuotato completamente, vanificando il concetto e riducendolo a mera diatriba tra bella/brutta.
Tutto questo funziona per il brand? Probabilmente sì. Ce n’era davvero bisogno, per aumentare le vendite o supportare la già ben definita brand awareness? Immagino di sì. Ci interessa? Non tanto.
Tutto questo marketing potrà, incidentalmente, anche contribuire davvero alla causa? Chissà. Questo ci interesserebbe.

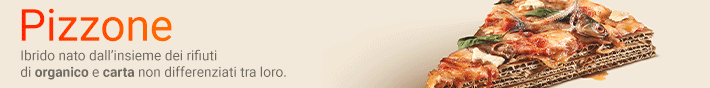





Ultimi commenti
che forza i reggiani! inarrestabili e inamovibili, brontolano per 5 anni e poi via testa bassa e pedalare! certo che il primo che dice qualcosa
Elezioni Europee, Elezioni Regionali, si fanno nomi, posti, e altro senza però parlare di programmi, quelli sono irrilevanti e fumosi, i soldi mancano per ogni […]
Eppure i sigg.ri draghi e meloni, ultimi due premier in carica nel nostro paese, nostro si fa per dire, vanno dicendo da più di due […]