Nella Milano operaia e socialista, industriale e futurista, eccitata e sgomenta per la guerra di Libia, nacque, nel 1912, il primo periodico nazionale delle donne socialiste. Tenacemente voluto e diretto da Anna Kuliscioff, compagna di Filippo Turati, la rivista seppe raccogliere in breve tempo l’adesione e la collaborazione di molte intellettuali già impegnate in politica, nelle arti, nel sindacato, nell’insegnamento e in generale a tutte le lavoratrici. Del carattere e delle finalità della rivista Anna scrisse: “è una guida moderna per l’allevamento fisico e morale dei vostri figli, e colle novelle, colle voci dai campi e dalle officine, coi dialoghi presi dl vero, porta sollievo, mentre colle notizie riguardanti le agitazioni e la propaganda e colle corrispondenze vi affratellate le compagne che lottano per gli stessi principi”.
Furono, infatti, pubblicati articoli politici, racconti, novelle, si affrontarono i temi della condizione femminile, della vita delle classi disagiate, si ribadì il diritto delle donne al voto, a una giusta paga e al diritto d’istruzione. Anna considerò sempre la battaglia per l’emancipazione delle donne e dei bambini come parte decisiva della più generale lotta del proletariato per una società socialista. Fu sempre convinta della necessità di collegare la lotta per le riforme economiche e sociali con quella per i diritti civili e politici.
Nei 23 anni di vita della rivista, chiuse nel 1925 a seguito delle leggi liberticide volute da Mussolini, comparvero articoli firmati da una numerosissima schiera di “donne combattenti”, che qui risulta difficile ricordarle tutte. Diffusa in tutta la penisola, la rivista riscosse un notevole successo non solo tra le donne di città e della campagna, ma fu molto apprezzata nel partito, che ne promosse la diffusione e ne sostenne i costi con diverse raccolte di fondi.
La redazione era stata posta al n. 23 della Galleria di Milano, nel salotto di Anna Kuliscioff (1857-1925), che ospitava anche quella di Critica Sociale, nata nel 1891, per merito sempre della Kuliscioff e Turati.
Presenza praticamente fissa in quelle stanze fu quella di Angelica Balabanoff (1878-1965), altra esule russa ed ebrea come Anna.

Le due donne coltissime e poliglotte, dal passato quasi identico, in realtà ora militavano nello stesso partito ma su sponde contrapposte, essendo la prima una convinta riformista e la seconda una intransigente massimalista. Le loro divergenze però cadevano nel lavoro della rivista, quando cioè si trattava di impostare le battaglie per l’emancipazione delle donne o per conquistare il diritto di voto. Fu proprio Angelica a subentrare ad Anna come direttrice del giornale, quando per motivi di salute la Kuliscioff nel 1914 diede le dimissioni.
Anna si era laureata in medicina, con una tesi sull’origine batterica delle febbri puerperali e delle cause delle morti post mortem. Per la sua attività a favore dei più bisognosi era chiamata la “dottora dei poveri”.
Angelica, chiamata la “missionaria del socialismo”, conosceva e stimava Rosa Luxemburg e Lenin, ed era in grado d’incantare le folli con una oratoria da predicatrice. Ogni tanto nell’appartamento in piazza Duomo faceva la sua presenza anche un giovane rivoluzionario romagnolo che Angelica aveva conosciuto a Losanna nel 1904 e per il quale sentiva un trasporto non solo politico. Fu lei ad educarlo ai testi del marxismo e alla cultura europea, fornendogli gli strumenti per risollevarsi dallo stato di miseria e disperazione nei quali si trovava. Di lei Mussolini ancora negli anni trenta dirà: “Se non l’avessi incontrata in Svizzera, sarei rimasto un piccolo attivista di partito, un rivoluzionario della domenica”.
Anna al contrario non gradiva le sue visite stimandolo un estremista invasato e ignorante, al quale addebitava l’esito del congresso di Reggio Emilia, che aveva decretato l’espulsione dei riformisti di destra di Bissolati e, una volta diventato direttore dell’Avanti!, l’allontanamento dell’amatissimo Claudio Treves.
Con la svolta interventista di Mussolini nel 1914, considerato un vero e proprio tradimento di tutto quello fatto e detto in precedenza, anche Angelica non avrà pace e non cesserà mai di denunciare il suo tradimento in Italia e all’estero. Lasciò testimonianza del suo sprezzante giudizio sul capo del fascismo nel libro Ricordi di una socialista e ne Il traditore. Ritornata in Italia dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, pentita d’aver creduto in Lenin e nella rivoluzione bolscevica, aderì al partito socialdemocratico di Giuseppe Saragat, ricongiungendosi così anche idealmente all’amica e compagna Kuliscioff.
La terza donna importante del “salotto” fu la veneziana Margherita Grassini (1880-1961), anche lei ebrea e sposata con l’avv. Cesare Sarfatti, che una volta conosciuto il futuro Duce disse alla moglie: “Segnati il suo nome perché questo giovanotto sarà l’uomo del futuro”. E Margherita fidandosi del marito diventò presto la sua amante, allontanandolo definitivamente da Angelica.

Per molti anni rappresentò la fonte d’ispirazione, la consigliera, l’oasi di pace dell’animo inquieto di Mussolini. Scrisse Dux, la biografia forse più famosa al mondo del dittatore italiano, per poi pentirsene amaramente quando anche lei rimase vittima delle leggi razziali del 1938 e fu costretta all’esilio negli USA.
Nella sua esperienza alla Difesa delle lavoratrici Margherita condivise tutte le battaglie per l’emancipazione della donna e tutte le scelte della redazione, non negando mai il suo contributo di idee, anche in campo artistico, essendo una stimata e competente critica d’arte.

È lecito dunque concludere che tra il 1912 e il 1914 tre donne tra le più influenti politiche del tempo, si incontrarono nel “salotto” di casa Kuliscioff dedicandosi alla comune battaglia dell’emancipazione della donna.
Le loro strade in seguito si separarono, militando anche su sponde politiche opposte. Furono comunque sempre tre donne libere, coraggiose, intellettualmente oneste, tanto da riconoscere e denunciare pubblicamente i loro errori.
Tra illuminazioni e abbagli, tra errori, contraddizioni e drastici ripensamenti, quelle tre donne vissero e interpretarono a modo loro, nel bene e nel male, le anime politiche che determinarono le sorti dell’Italia negli anni avvenire: quella socialista e quelle comunista e fascista.
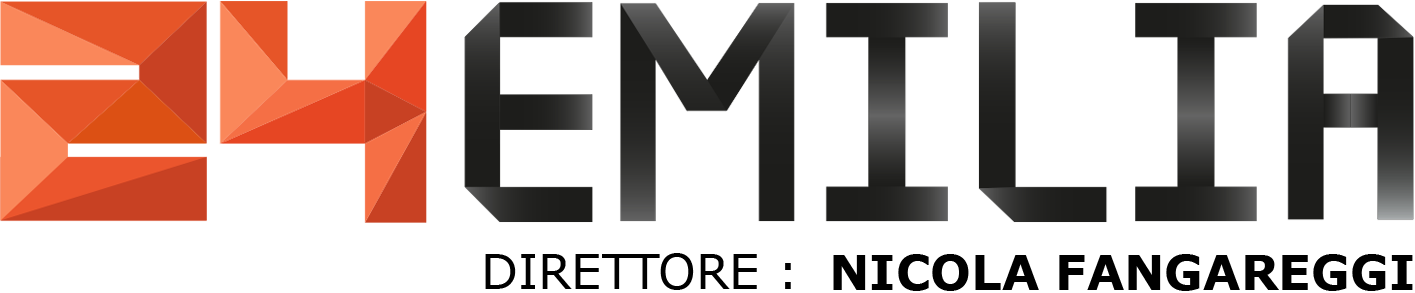




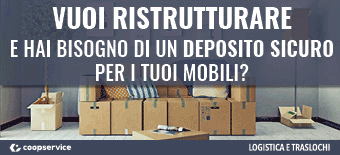

Non ci sono commenti
Partecipa anche tu