Un effetto universale il coronavirus lo ha avuto: più di ogni predica, ha convinto tutti della fragilità dell’uomo. Anche coloro che lo negano, che lo sfidano, che hanno comportamenti irresponsabili, stanno cercando di rimuovere un pensiero che si è piantato come un arpione nella loro carne. Il moralista potrebbe essere contento di questo “ritorno alla realtà”. Purtroppo, questo significa, per molte persone, tristezza, ansia, depressione. Il rischio è una coltre pesante e universale di pessimismo.
Questa non è la volontà di Dio. Egli vede molto meglio di noi i limiti e le miserie dell’uomo; ma il suo sguardo non è quello del giudice, ma del Padre. Gesù, infatti, dice: “Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”(Gv 10,10).
Tuttavia, quello che egli propone, è un percorso paradossale: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà” (Mt 16,24s.).
Nelle parole di Gesù, ci sono un presente e un futuro; c’è una promessa, che vuole dilatare la speranza dell’uomo all’eternità. Già questo è importante. L’angoscia dell’uomo di fronte ai propri limiti, è in realtà il rifiuto della morte. Gesù dice che l’ultima parola non è la morte, ma la vita. Questo dovrebbe aiutarci a orientare i nostri desideri e a trasformare l’esperienza della fragilità nella ricerca del nostro vero bene: “Quale vantaggio avrà un uomo, se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita?”
C’è però qualcosa di più nelle parole del Cristo: questa “vita” non è semplicemente futura, dopo la nostra morte, ma è già presente oggi. Certamente, è presente come il lievito nella farina, come il seme nascosto nella terra: ma essa fermenta già ora l’esistenza del discepolo e il segno è la gioia: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”(Gv 15,11).
Gesù non dà giustificazioni ma propone una scommessa, un rischio. Non si può giustificare la croce, ci si può solo fidare della sua promessa e seguirlo: “Chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà”.
Possiamo però cercare di raffigurarci questa croce, attingendo dalla nostra esperienza. La prima forma è l’accettazione della quotidianità. E’ bello avere degli ideali ed è giusto fare dei progetti. Ma a un certo punto della vita si debbono fare i conti con i limiti: il lavoro che logora, il lavoro precario, le esigenze degli altri membri della famiglia, le malattie, gli acciacchi dell’età. E’ facile continuare l’elenco. Non c’è bisogno del coronavirus, per rendersi conto che possono insinuarsi in noi la tristezza e il risentimento.
C’è un’altra via, quella della mitezza. Il punto di partenza consiste nell’accettare la nostra realtà, certi che essa è la nostra via, anche se non ne conosciamo le tappe e i tempi. E’ nostra, perché l’accogliamo dalle mani di un Padre. Col tempo, cresce in noi una sapienza, che riesce a dare significato anche al sacrificio: ad esempio, comprendiamo che il lavoro serve al bene, al bene comune, quello della famiglia, ma anche di altri, e diviene un atto di amore. Comprendiamo che l’ideale non può fare a meno della persuasione e che è meglio accettare una sconfitta, pur di fare un pezzo di strada insieme.
Mi pare che sia questa la “sapienza del cuore”(Salmo 90,12), che ci insegna a “contare i nostri giorni”. Se rinunciamo alla presunzione, acquistiamo la serenità. “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, dice Gesù. Certamente, “non come la dà il mondo, io la do a voi” (Gv 14,27). Questa pace è infatti l’anticipo di quella comunione con Dio e con la Chiesa celeste, che noi possediamo e possiamo diffondere a chi ci sta intorno.

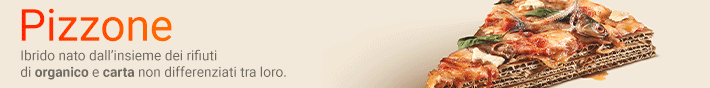





Ultimi commenti
Elezioni Europee, Elezioni Regionali, si fanno nomi, posti, e altro senza però parlare di programmi, quelli sono irrilevanti e fumosi, i soldi mancano per ogni […]
Eppure i sigg.ri draghi e meloni, ultimi due premier in carica nel nostro paese, nostro si fa per dire, vanno dicendo da più di due […]
Visto come sta andando a Gaza, la Nato potrebbe considerare il lancio di due bombe nucleari tattiche su teheran da parte israeliana una reazione