Quinta Domenica di Pasqua, Anno C – 19 maggio 2019
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35)
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Il fascino dei discorsi con i quali Gesù prende commiato dai suoi discepoli (capitoli 13-17 del vangelo di Giovanni) sta anche nel linguaggio, apparentemente semplicissimo, ma in realtà così denso da sembrare quasi esoterico.
Che cosa vuol dire infatti “glorificazione”? Giuda è appena uscito, la grande tragedia sta per cominciare e si compirà sul Golgota, nell’atroce supplizio della crocifissione. Vergogna, fallimento; non gloria!
Ma se “gloria” significa la piena rivelazione di chi è Dio e di chi è Gesù, allora si può parlare veramente di una “gloria della croce”. Gesù ha dato il via, con sovrana libertà, al sacrificio della sua vita: ma questo sacrificio rivela l’intimità del rapporto tra Gesù e Dio.
Gesù afferma oltre ogni limite che Dio è Padre, che non abbandona neppure nella morte, e la sua consegna filiale giunge al dono della vita. Ma, nello stesso tempo, Dio si rivela in quell’uomo crocifisso: chi sia Dio, non lo diranno più i filosofi e neppure i sacerdoti delle religioni, gli specialisti del culto.
Infatti qual è la “gloria” della Croce? È la sua forza totalizzante: nulla e nessuno viene respinto: non il misero, non il peccatore, non lo schiavo, non l’angosciato, neppure l’ateo, se Gesù stesso ha detto: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.
La Croce è l’ostacolo che Nietzsche non è riuscito a superare, nella sua pedagogia dell’”uomo superiore”: la Croce rende impossibile ogni frazionamento castale dell’umanità e permette a Dio di raggiungere l’ultimo degli uomini e a questi di aspirare a partecipare alla vita divina.
L’amore diventa così una forza inclusiva e universale, che frantuma ogni appartenenza particolare, non per uno sforzo volontaristico richiesto agli animi nobili, ma per un fatto ormai irreversibile: come dice Paolo, “Uno è morto per tutti. Quindi, tutti sono morti”, cioè ogni identità precedente è giunta al suo termine e tutto ricomincia per coloro che si pongono di fronte a quell’Uno.
Comprendiamo allora anche la frase che segue: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Quel “come” non ha un valore semplicemente comparativo, quasi che Gesù si proponga come modello e quindi rivolga un’esortazione morale; esso è un “come” fondativo, un po’ come il nostro ”siccome”: proprio perché io vi ho amato fino alla Croce e così ho abbattuto le barriere tra voi e il Padre, ora voi potete amare, avete la libertà di amare, avete in voi un principio nuovo, che sorregge il vostro impegno morale.
Così si spiega anche l’ultima frase: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”. L’amore che i discepoli avranno gli uni per gli altri avrà un’efficacia nella storia: verrà rivelato a tutto il mondo che i discepoli sono discepoli di Gesù, ma non semplicemente per il fatto di un’appartenenza storica o ideologica.
Verrà rivelata al mondo la forza dell’essere discepoli di Gesù. L’amore dei discepoli gli uni per gli altri, sul fondamento dell’amore di Gesù, ha un’efficacia pubblica, oserei dire politica: viene resa presente nella storia la forza della presenza di Gesù.
I cristiani glorificano Dio non soltanto con la santità di alcuni membri eletti, ma anche e soprattutto con la testimonianza: “Ero un peccatore e sono stato perdonato, ero nell’impotenza di fare il bene e mi è stata donata una nuova libertà”. Gli uomini hanno bisogno di questo.
Ne ha bisogno anche la Chiesa. Veniamo da secoli di competizione con la forza e la sapienza del mondo: l’apparato dottrinale, morale e istituzionale ha logorato le forze della Chiesa e genera spesso pessimismo, di fronte alle difficoltà, ai rifiuti e anche di fronte alla realtà delle fragilità umane all’interno della stessa Chiesa.
Ma sempre di più, nella povertà e anche nella sofferenza, la Chiesa riscopre la forza del messaggio: “Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio”. Di questo gli uomini hanno bisogno, sempre. Essi desiderano una Chiesa fraterna, uomini e donne che si mettano a fianco di chi cerca, magari dolorosamente e talvolta sbagliando; uomini e donne che sappiano aiutarli a leggere ciò che lo Spirito compie in loro, che li aiutino a consegnarsi al divino Ospite che bussa alla loro porta.
Mi sembra che sia questo il messaggio di Papa Francesco nel suo documento programmatico “Amoris laetitia”: la cosa più importante è l’orientamento deciso verso un modo di essere Chiesa che “accolga, accompagni, discerna e includa”.
Qui si vede l’importanza “politica” di questo messaggio. Infatti, in questo nostro mondo, noi assistiamo sempre più a respingimenti, competizioni che creano marginalità, giudizi che separano, muri che escludono. Se consideriamo gli atti di questo pontificato, verso le famiglie in difficoltà e verso i profughi, vediamo che non si tratta solo dell’interesse verso emergenze di grande peso, ma dello sforzo di sviluppare il paradigma che papa Francesco intende per il rapporto tra la Chiesa e il mondo.
L’andare verso le “periferie esistenziali” è importante per la Chiesa, per evitare chiusure e arroccamenti. Non è facile conciliare la fedeltà alla propria identità e l’apertura verso ogni uomo, ma è proprio questa l’immagine di Chiesa che il suo Fondatore ha voluto.
La vediamo descritta nel libro dell’Apocalisse. Si dice, della Città santa, della Nuova Gerusalemme: “Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni” (21,24-26).
Il muro indica l’identità, ma le porte sempre aperte, notte e giorno, indicano l’accoglienza. Vi è allarme, in certi ambienti, perché si temono i compromessi sulla dottrina e il “tradimento” dell’identità della Chiesa. Penso che il vero tradimento della volontà di Gesù sarebbe una Chiesa separata dal mondo, quel mondo per il quale Gesù è morto in croce.
Quel mondo, come sistema di valori, era il nostro, ne abbiamo misurato la forza negativa, la capacità di corruzione. Ma ora possiamo rendere testimonianza, di fronte a quello stesso mondo, di una libertà che ci è donata per mezzo della Croce e che ci impegna a vivere una vita nuova nell’amore.
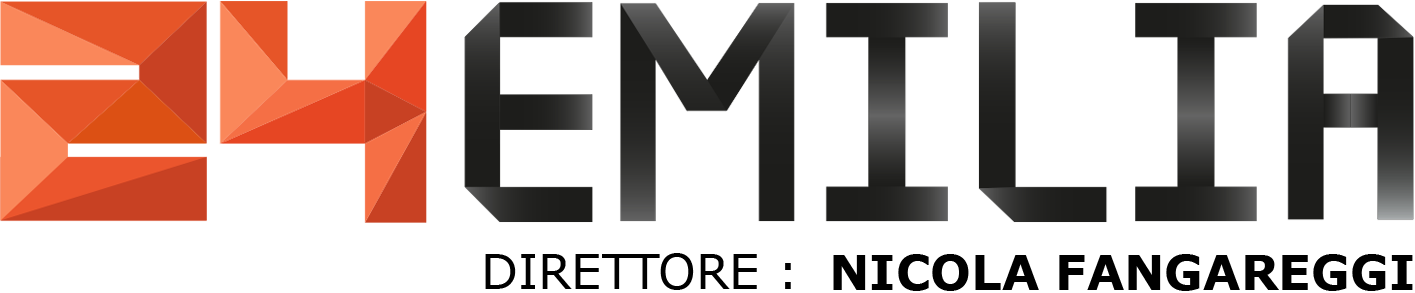

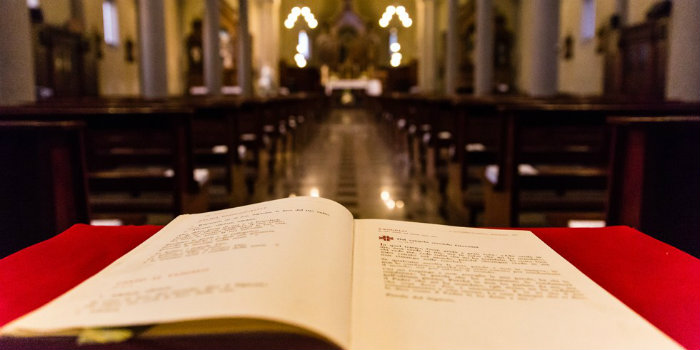


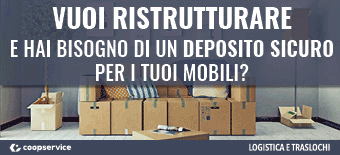

Ultimi commenti
No ti sbagli, quelli arrivarono durante il COVID a Bergamo, con Conte e il PD...
No è solo x certi ignoranti che si credono divertenti
Invece di preoccuparvi di cose inutili, dovevate avere rispetto per 60mila persone senza mezzi pubblici, taxi, ncc e uber che han dovuto camminare per km