Ogni tanto un Comune, stanco di occuparsi di buche stradali e degrado civile, scopre di avere una missione universale. Non basta amministrare: bisogna dialogare con il mondo. Nasce così la fondazione pubblica – totalmente pubblica, ma elegantemente non comunale. Una creatura ibrida, che vive di bilancio municipale e respira come se fosse un centro studi delle Nazioni Unite. Si parla di ponti, reti, cittadinanza globale.
La città, nel frattempo, continua a litigare per i parcheggi, l’insicurezza, lo sfascio commerciale. È una forma di sublimazione amministrativa. I problemi concreti dell’immigrazione – casa, lavoro, spaccio, conflitti di vicinato – vengono tradotti in linguaggio alto: “dialogo interculturale”. Che è sempre una buona cosa, purché non sostituisca ciò che dovrebbe accompagnare. Max Weber ricordava che la politica è “lenta perforazione di tavole dure”. Ma perforare tavole è faticoso; molto meglio organizzare un tavolo. Rotondo, possibilmente. Con relatori.
La fondazione totalmente finanziata dal Comune diventa così una piccola Farnesina urbana. Si accredita, media, rappresenta. Resta solo una domanda, discretamente provinciale: chi rappresenta chi? Le comunità non sono ambasciate, e le città non sono Stati sovrani, anche se talvolta ne imitano il lessico. Naturalmente queste strutture producono anche capitale simbolico. È inevitabile: chi frequenta i luoghi del discorso pubblico impara a usarlo. Non c’è nulla di scandaloso. È la dinamica normale del potere locale, che si forma nei corridoi della cultura prima di entrare nelle stanze della politica.
Il punto non è morale, è proporzionale. Se una fondazione vive interamente di risorse pubbliche, dovrebbe essere misurata come un servizio, non come un manifesto. Perché – per citare Tocqueville – le istituzioni democratiche si giudicano meno dalle intenzioni che dagli effetti. E gli effetti, di solito, si vedono nei quartieri. Non nei convegni.

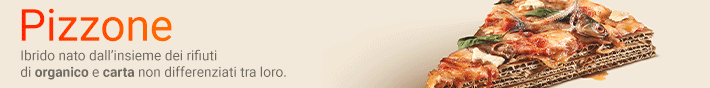






Non ci sono commenti
Partecipa anche tu