Nel cammino verso il Natale, la Chiesa ci presenta la figura di Giovanni il Battista. Egli è un messaggero di “conversione”. Che cosa significa questa parola? Noi la traduciamo nella riforma della nostra vita, nel distacco dai nostri difetti. Certo, questo è importante, ma rischia di essere interpretato come uno dei tanti messaggi un po’ moralistici che riceviamo in occasioni come il Natale: l’invito a essere più buoni, più generosi.
Proviamo a dare a questa parola, conversione, un contenuto più forte, più “pesante”.
Convertirsi vuol dire anzitutto voltarsi, dirigere lo sguardo a qualcosa che ci viene incontro. Il primo a convertirsi, allora, è Dio; secondo Giovanni, è lui che viene a incontrare il suo popolo smarrito, che “giace nelle tenebre e nell’ombra della morte” (Lc 1,79). Convertendosi, venendoci incontro, Dio crea uno spazio di speranza, per l’uomo che tante volte ha sperimentato la fragilità dei suoi propositi.
Chi ha udito questo messaggio, capisce che non può tenerlo per sé, ma che deve trasmettere la speranza, mediante esperienze e segni. I segni di speranza sono stati elencati da papa Francesco, quando ha inaugurato il Giubileo, che si concluderà il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2026. In sostanza, essi sono due: il desiderio di trasmettere la vita e l’accoglienza. Il papa elenca tante persone che aspettano di essere accolte: carcerati, ammalati, giovani, migranti, anziani, poveri. Praticamente, tutti, perché prima o poi ciascuno di noi vive o vivrà un’esperienza di povertà.
Accogliere non è però una cosa semplice. Mi piacerebbe parlare dell’accoglienza come stile della politica, della vita pubblica; mi limiterò a parlare dell’accoglienza reciproca nelle comunità cristiane. Essa è una delle preoccupazioni principali dell’apostolo Paolo. Per esempio, nella Lettera ai Romani scrive: “Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio” (15,7). Il tono è accorato, quindi questa accoglienza reciproca non doveva essere cosa facile.
Qualche informazione l’abbiamo, sul clima delle comunità. Le prime erano comunità miste, formate da credenti che venivano dal giudaismo e da pagani convertiti. È comprensibile che si portassero dietro qualche elemento della loro cultura d’origine. Gli ebrei chiamavano i pagani “cani” e venivano ripagati col titolo di “nemici del genere umano”. Paolo vede nella concordia degli uni con gli altri un miracolo, la prova che la fede cambia davvero i cuori, il modo di vedere la realtà. Il suo manifesto è la Lettera ai Romani, che conclude l’argomento così: “Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti” (11,32). Tutti: senza differenze.
Veniamo ora alle nostre comunità. Anzitutto, purtroppo non ci sono membri di origine ebraica. Ma, almeno, dovremmo rifiutare ogni parola e ogni gesto che possano avere un anche minimo inquinamento di antisemitismo.
Dovremmo poi chiederci con quale atteggiamento partecipiamo ai riti sacri. Su questo punto ha insistito molto il Concilio Vaticano II, chiedendo di superare la visione individualistica della Messa. Una Messa che non venga vissuta nella carità verso l’altro, non è “cristiana”. Il fondamento dell’unità è infatti nell’aggiunta “come Cristo accolse voi”. Entrando in chiesa, dovremmo sentirci dei poveri pellegrini: poveri, perché senza titoli di merito, anzi, gravati dalle nostre ricadute nel peccato di Adamo, la superbia, che ha poi come effetto la violenza; pellegrini, perché non proprietari, ma amministratori, per il bene comune, dei doni che abbiamo ricevuto, aspirando non al successo, ma a essere riconosciuti dal Padrone: “Bene, servo buono e fedele; entra nella gioia del tuo Signore” (Mt 25,21).
Possiamo fare un piccolo test su noi stessi. Quante persone conosciamo per nome, tra i partecipanti alla Messa? Con chi ci fermiamo a parlare, quando usciamo sul sagrato? Forse, sempre con gli stessi?
Secondo me, quando papa Francesco parlava di “Chiesa in uscita” non sollecitava al proselitismo, quanto invece a spezzare i muri immateriali che circondano l’uomo, i pregiudizi, le classifiche dei più e dei meno simpatici.
Secondo me, avremmo una ricompensa immediata, la gioia; vivremmo la diversità come arricchimento. Allargando la prospettiva, chissà che la divisione tra noi e la Chiesa russa non sia la ferita curando la quale potremmo dare forza al desiderio di pace. Tendiamo a mettere in risalto i difetti, spesso reali e molto gravi. Ma l’apostolo dice: “Gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12,10).

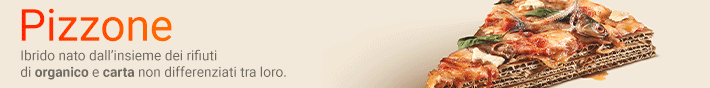






Non ci sono commenti
Partecipa anche tu