Nel 1935, uno studioso tedesco, Erik Peterson, pubblicò un saggio, intitolato “Il monoteismo come problema politico”. Egli si chiedeva come mai gli imperatori romani, dopo Costantino, avessero aderito all’immagine di Dio delineata da Ario, un presbitero di Alessandria d’Egitto, condannato invece dalla Chiesa ufficiale nel concilio di Nicea dell’anno 325. Questo interesse teologico del potere imperiale è in effetti piuttosto singolare. Lo si comprende, quando si pensa che Ario, rifacendosi alla filosofia platonica, immaginava la realtà secondo un’immensa scala gerarchica. Il Dio uno, unico vero Dio, al vertice; poi una serie di mediatori, primo fra i quali il Figlio, invocato come Dio, ma per modo di dire. Il “monoteismo” ariano diveniva la base teologica del potere: l’imperatore era il rappresentante della divinità: un solo Dio, un solo imperatore. Il potere si distribuiva, poi, secondo una serie di gradi, che trovavano nel Dio unico e, più concretamente, nell’imperatore, la fonte della loro autorità.
La mediazione tra il supremo principio e le creature era affidata alla Chiesa, che rischiava così di diventare instrumentum regni, supporto al potere politico. Formalmente, il mediatore primo era il Figlio incarnato: in realtà, la mediazione avveniva attraverso la Legge. Non è un caso che, tra le fonti dell’Islam ci siano, sembra, ambienti giudeocristiani. Infatti, nell’Islam il mediatore non è Maometto, ma il Corano.
Gesù, in realtà, libera Dio dalla legge. Il suo rapporto con Dio è racchiuso nella parola “Padre”. Egli si richiama alla grande tradizione biblica, secondo la quale, prima della legge, c’è l’”alleanza”, alla quale la legge serve come ancella, lasciando però al Padre celeste la sua libertà e imprevedibilità. Il Dio d’Israele è un Dio appassionato, che ama il suo popolo, pur conoscendone i limiti e le infedeltà. L’immagine che i profeti adoperano è quella di un rapporto sponsale, nel quale c’è spazio per l’ira e la gelosia dello Sposo divino, tante volte tradito con gli idoli mondani, ma poi sempre disponibile al perdono. Questa volontà di alleanza, di comunione arriva al sacrifico del Figlio: “Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza”, dice Gesù consegnandosi all’uomo.
Ci si chiede quale sia la ragione di questo innamoramento, quando sembra che ci sia così poco da amare, ascoltando le cronache di Ucraina e di Gaza. La ragione non sta nell’uomo, ma nell’essenza più intima del Dio di Gesù, che è l’amore. Ma l’amore è universale ed eterno, proprio perché ha la sua radice in Dio. Tutti sono chiamati, tutti sono figli, anche quelli che abbandonano la casa paterna ma sanno che possono ritornarvi, anche coloro che si sono corrotti, anche chi ha commesso delitti innominabili. La ragione della morte atroce del Figlio unico sta nel colpo di lancia del soldato: da quella ferita, sgorga l’acqua viva, che, nella visione di Ezechiele, fa fiorire il deserto.
Parlavo prima di un Dio imprevedibile. Chi poteva pensare a un’assurdità come la croce? Paolo di Tarso lo dice benissimo: “Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, follia per i pagani”. In effetti, egli venne perseguitato a morte da coloro che, nella legge, vedevano la tutela dell’ordine pubblico. Egli però ha fatto l’esperienza sia dell’uso assassino della Legge, sia del perdono e della libertà donati dal Crocifisso: “Per coloro che sono chiamati, tanto Giudei che pagani, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio” (1Cor, cap.1). Siamo grati ai vescovi radunati a Nicea, per aver condannato Ario e per aver rivendicato a Dio la libertà di amare i peccatori. Non è però facile, neanche per la Chiesa, rinunciare alla sicurezza della legge, dei riti e delle gerarchie. Ma qui entra in gioco il Terzo, l’ignorato, la fonte della libertà, lo Spirito Santo: “Dove c’è lo Spirito del Signore, ivi è libertà” (2Cor 3,17). “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità” (Gv 16,12s.).
La verità pesante è l’amore di Dio per l’uomo, per ogni uomo.
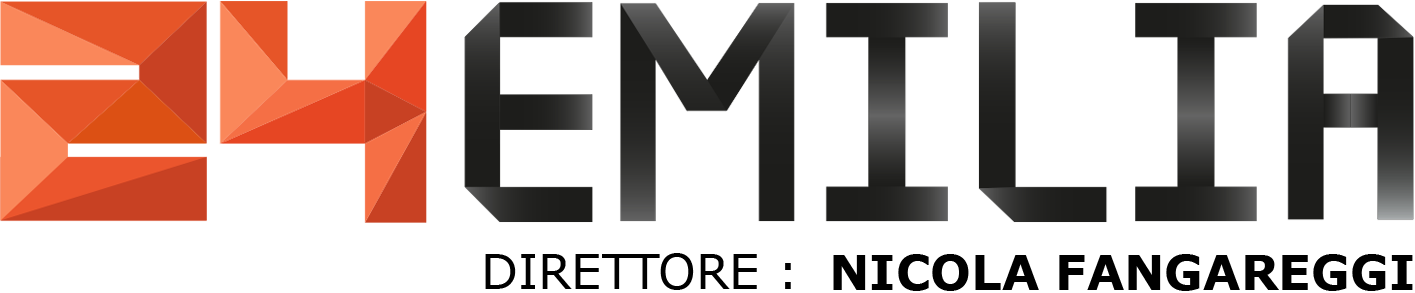




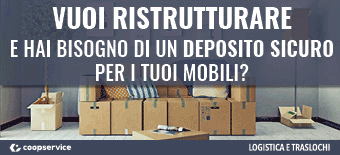

Non ci sono commenti
Partecipa anche tu