Quarta Domenica del Tempo Ordinario, Anno C – 3 febbraio 2019
Dal vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?».
Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
In questo racconto, ci sono molte cose che sorprendono. Prima di tutto non si capisce la ragione di questa volontà omicida: dopotutto bastava non dar retta, considerare Gesù un invasato. Il figlio di Giuseppe, il nostro carpentiere, si è montato la testa!
Ancora, sono i pacifici abitanti di Nazaret, brava gente religiosa, a volere la morte di uno che non può essere accusato di nulla, tanto meno di bestemmia. Ma questo è solo l’anticipo di una domanda che ritroveremo nei vangeli fino alla fine: perché tanto accanimento? Perché quest’uomo viene visto come un pericolo così grave, che se ne richieda la morte?
La domanda vale anche oggi. Sta crescendo un’intolleranza violenta, nella quale la religione sembra avere un ruolo importante. Lo si vede nell’Islam, nell’ebraismo e anche nel cristianesimo: mi sorprende il tono pieno di aggressività e di livore con il quale certi ambienti e certi giornali attaccano papa Francesco al punto di accusarlo, neanche troppo velatamente, di eresia, di stravolgimento della dottrina cristiana. Perché mai?
Una prima risposta può essere che Gesù disturba la buona coscienza di uomini che hanno fatto di Dio la loro polizza d’assicurazione: la religione viene sentita come un fattore d’ordine, di sicurezza. Di conseguenza chi parla – come papa Francesco – di “una Chiesa in uscita verso le periferie del mondo” introduce l’esigenza del cambiamento, del mettersi sempre in cammino, di un rinnovato “esodo”, di metri sempre nuovi di giudizio.
Ora, invece, quello che conta è il cuore, il riconoscere che la fede è un dono immeritato, che è l’opera non dell’uomo, ma di Dio, di un Dio che viene in soccorso di chi si è perduto. Non c’è gioia, negli abitanti di Nazaret, perché in sostanza pensano di non aver bisogno, di essersi già messi a posto col loro Dio, di avere diritto a un premio per la loro buona condotta. Per questo il vedersi retrocessi dietro a stranieri, come la vedova di Sidone o Naaman il Siro, li offende, anzi, turba il buon ordine delle cose, la ragionevolezza di un mondo basato sulla moralità.
Al contrario, gli stranieri sono consapevoli che non hanno diritto a nulla, che hanno ricevuto “grazia” (anche nell’odierno testo evangelico ricorre questa meravigliosa parola) in modo inatteso e sorprendente: alla grazia, alla gratuità corrisponde la gratitudine. Ecco il rischio della religione e della moralità: dimenticare la nostra povertà e il nostro bisogno, perdere il senso della parola “salvezza”, presumere l’autosufficienza.
Dovremmo, invece, pensare che siamo tutti stranieri: “Mio padre era un Arameo errante”, così comincia la professione di fede del Deuteronomio (26, 5). Siamo stranieri in questo mondo, se non altro perché siamo mortali e dovremo lasciare tutto; ma siamo ancora più profondamente stranieri: “Ricordatevi che eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo” (Lettera agli Efesini 2, 12).
Chi si considera padrone costruisce muri per difendere le sue proprietà; chi sa di essere straniero e amministratore di beni non suoi si rende meglio conto di quello che ci ricorda la seconda lettura della liturgia odierna: solo “tre cose rimangono, la fede, la speranza e la carità; ma la più grande di tutte è la carità” (1 Corinzi 13).
Di conseguenza, la legge morale dà certamente un’indicazione, ma non può mai diventare motivo per compiacersi di se stessi, se viene osservata. Infatti la carità va ancora più nel profondo, rispetto alla legge, perché la carità è Dio e nessuno può dire “Ho amato abbastanza”.
Nello stesso tempo, il Signore accoglie Naaman il Siro e la vedova pagana, che probabilmente non erano in pari con la legge di Mosè. In altre parole Gesù, come dice Paolo di Tarso nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 3, non ci consegna una legge scritta su tavole di pietra, ma scritta nel nostro cuore: è il suo appello a crescere ogni giorno, a ripartire sempre nella ricerca di una maggiore fedeltà alla “grazia” che abbiamo ricevuto.
Si tratta di una legge nello stesso tempo più leggera, perché non impone, ma accoglie, orienta e nello stesso tempo incoraggia e consola; ma è anche una legge più esigente perché, come si diceva, la legge di Gesù è in definitiva Dio stesso e le esigenze della comunione con Lui.
Non imponiamo dunque pesi gravi e pesanti all’uomo, soprattutto all’uomo che ha vissuto senza la legge, magari soffocando per lungo tempo la voce che parlava al suo cuore, ma che riscopre l’inquietudine, il desiderio di verità e di bontà: a quest’uomo dobbiamo portare “parole di grazia”, esortandolo e accompagnandolo nel rispondere al dono.


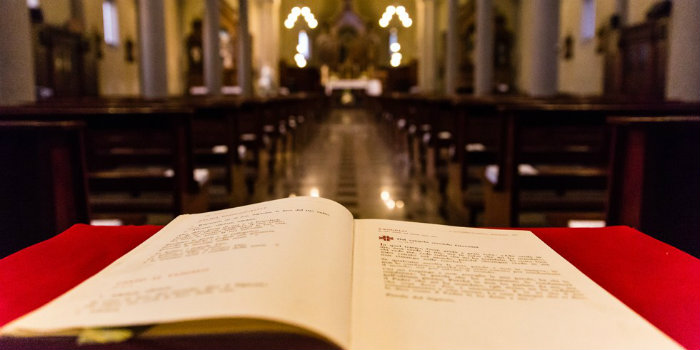




Ultimi commenti
No ti sbagli, quelli arrivarono durante il COVID a Bergamo, con Conte e il PD...
No è solo x certi ignoranti che si credono divertenti
Invece di preoccuparvi di cose inutili, dovevate avere rispetto per 60mila persone senza mezzi pubblici, taxi, ncc e uber che han dovuto camminare per km