Negli ultimi due decenni una visione dell’evoluzione umana ha smesso di appartenere tanto alle scolastiche narrazioni darwiniste quanto alle distopie fantascientifiche, per diventare un programma operativo. Non si tratta più soltanto di immaginare futuri possibili, ma di finanziarli, progettarli, implementarli.
Elon Musk e Peter Thiel, giganti del tech tra i primi a sostenere Donald Trump, sono tra i protagonisti più influenti di questo passaggio, figure diverse per stile e biografia, ma accomunate da una convinzione di fondo: l’uomo, così com’è, è un sistema imperfetto, lento, strutturalmente inadeguato alla potenza dei processi che ha messo in moto.
In questa prospettiva, l’evoluzione biologica appare un meccanismo cieco, lento e obsoleto. La selezione naturale ha prodotto un cervello fragile, esposto a bias cognitivi, emozioni disfunzionali, limiti di attenzione. La tecnica, invece, promette ottimizzazione: intelligenze artificiali più affidabili del giudizio umano, interfacce cervello-macchina capaci di aggirare i colli di bottiglia della coscienza, biotecnologie e innesti cyborg orientati non più solo alla cura ma al potenziamento. L’evoluzione, per la prima volta, può essere presa per mano e condotta in una certa direzione.
Questa visione non è unitaria, né sempre esplicitata. Musk la declina in chiave difensiva (l’IA può diventare una minaccia esistenziale e va integrata prima che ci superi), Thiel in chiave più apertamente filosofica e politica. È su quest’ultimo che vale la pena soffermarsi, perché la sua posizione rivela radici meno ovvie e più profonde.
Peter Thiel nasce a Francoforte sul Meno. La sua formazione culturale, pur sviluppatasi negli Stati Uniti (a Stanford fu allievo di René Girard), porta tracce evidenti di una sensibilità tedesca: attenzione alla filosofia politica, diffidenza verso il liberalismo procedurale, interesse per le grandi narrazioni sul destino dell’Occidente.
Non è un caso che abbia più volte dichiarato la propria ammirazione per Leo Strauss (P. Thiel, “Il momento straussiano”, Liberilibri 2025), il filosofo tedesco-americano che ha criticato il relativismo moderno e difeso l’idea che le società siano sempre guidate, in modo più o meno consapevole, da élite portatrici di verità profonde. Nel pensiero straussiano, la democrazia liberale non è il punto d’arrivo della storia, ma una forma fragile, esposta al nichilismo e all’appiattimento. In questo quadro, la tecnica (oggi l’IA) può diventare uno strumento di governo della complessità che l’uomo medio non è più in grado di gestire. Non sorprende allora che, nella visione thieliana, il problema non sia tanto se l’uomo verrà superato, quanto chi guiderà questo superamento.
Qui emerge il nodo decisivo: l’evoluzione come progetto guidato da concentrazioni di capitale e potere politico senza precedenti. Mai prima d’ora una visione antropologica ha potuto contare su risorse tanto vaste, su una capacità di implementazione tanto rapida, su un intreccio così stretto tra ricerca, industria, difesa e governance globale. Il transumanesimo contemporaneo non è un’utopia marginale: è un’agenda già operativa.
Mai come ora il monito di Hans Jonas risuona con forza. Jonas, filosofo ebreo-tedesco, sopravvissuto al Novecento e alle sue catastrofi, comprese prima di molti altri che la tecnica moderna introduce un fatto radicalmente nuovo: l’irreversibilità. Le nostre azioni non producono più solo effetti locali e temporanei, ma modificano le condizioni stesse della vita futura. Da qui il suo celebre “principio di responsabilità”: agire in modo che le conseguenze delle nostre azioni siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla Terra.
Jonas non era tecnofobo. Ma sapeva che, quando è in gioco la definizione stessa dell’umano, il peso della prova non può che gravare su chi vuole cambiare, accelerare, ottimizzare. La prudenza, in questo senso, non è conservazione, ma rispetto per ciò che non possiamo ancora pienamente comprendere.

E tuttavia, la sola prudenza rischia di non bastare. Qui si colloca la figura, spesso fraintesa, di Rudolf Steiner. Steiner non si oppose mai alla tecnica in quanto tale. Al contrario, vide con grande lucidità che l’evoluzione umana stava entrando in una fase nuova, in cui i processi esteriori avrebbero superato quelli interiori. Il pericolo, per lui, non era la macchina in sé, ma la sproporzione: a ogni passo in avanti dello sviluppo tecnologico avrebbero dovuto corrisponderne almeno due della coscienza, cioè di quella capacità di farsi immagini precise (tramite intuizione o fantasia morale) delle conseguenze delle azioni consentite dalla tecnica. Le cose, come sappiamo, non sono andate esattamente in questo modo.
Denunciando il rischio culturale di un’evoluzione guidata unilateralmente dall’efficienza e dalla correzione biologica dell’imperfezione (di straordinaria attualità sono le sue considerazioni sul ruolo della disabilità nella società moderna), preconizzò con intuizione visionaria l’avvento del nazismo, che infatti possiamo leggere come controimmagine rispetto all’antroposofia, come suggerito da Luca Negri nel suo recente “Tempo da lupi. La guerra occulta di Adolf Hitler contro Rudolf Steiner” (Edizioni Artemis, 2024). È precisamente questo slittamento antropologico, più che la singola tecnologia, a costituire, per Steiner, il vero pericolo.
La critica steineriana alla deriva transumanista non è dunque una difesa romantica dell’uomo “naturale”, ma una contestazione più radicale: l’idea che l’evoluzione possa essere ridotta a un processo tecnico-amministrativo, eterodiretto e concentrato nelle mani di pochi. L’uomo, in questa prospettiva, non è più soggetto dell’evoluzione, ma oggetto di un progetto.
A questa visione Steiner contrappone una concezione dell’umano come essere in divenire interiore, la cui incompletezza (o non-specializzazione) non è un difetto da eliminare ma la condizione stessa della possibilità della libertà. La vulnerabilità, l’indeterminatezza, persino l’inefficienza diventano così elementi costitutivi di una forma di esistenza che rende possibile il giudizio morale e l’assunzione di responsabilità. Dove il transumanesimo vede limiti da superare e un mondo libero dalla disabilità, dalla fragilità e dalla differenza, Steiner vede la condizione necessaria all’evoluzione dell’umanità.
Questo sguardo non si ferma all’individuo, ma si estende all’intero organismo sociale. La proposta della triarticolazione sociale, cioè la distinzione e autonomia reciproca tra vita culturale-spirituale, vita giuridico-politica e vita economica, nasce proprio dalla consapevolezza che il dominio di una sola dimensione (oggi quella economico-tecnologica) finisce per deformare l’umano in tutte le sue espressioni. Quando l’economia detta legge alla cultura e alla politica, anche l’idea di uomo tende a modellarsi sui criteri di produzione, rendimento, efficienza, controllo.
In questo quadro, la pedagogia Waldorf non rappresenta un’isola separata o un rifugio educativo, ma una manifestazione concreta di una visione più ampia: l’idea che la formazione dell’essere umano non possa essere subordinata né all’utilità economica né all’ottimizzazione funzionale. Essa è solo una delle soglie attraverso cui si tenta di preservare e rinnovare uno spazio di libertà interiore in un mondo sempre più orientato alla gestione tecnica dell’esistenza.
La distanza tra questa prospettiva e quella oggi dominante non potrebbe essere maggiore. Da un lato, un progetto evolutivo sostenuto da capitali e poteri politici senza precedenti, che mira ad accelerare, correggere e superare l’uomo così com’è. Dall’altro, una proposta che invita a rallentare lo sguardo, a interrogare il senso, a mantenere l’evoluzione come processo capace di trovare dentro di sé i motivi etici della sua dinamica (kantianamente, “la legge morale in me”), non mediante imposizioni esterne asservite a scopi “altri”.
Non si tratta, in ultima analisi, di scegliere tra tecnica e umanesimo. Si tratta di decidere se la tecnica debba essere il criterio ultimo dell’umano, o se l’umano possa ancora restare il criterio guida della tecnica. Steiner non chiede di distogliere lo sguardo dal drago della potenza tecnologica, né di sconfiggerlo; chiede, con “coraggio micheliano”, di sostenerne lo sguardo senza rinunciare alla propria interiorità.
E tuttavia, in questo stesso gesto è contenuta una consapevolezza più inquietante: che nulla garantisce l’esito di questo confronto. Il “progetto uomo” – inteso come conquista progressiva di una libertà capace di trovare nella propria interiorità i motivi della propria azione – non è assicurato da alcuna necessità storica né da alcun automatismo evolutivo. Può avanzare, trasformarsi, ma può anche arrestarsi o fallire, lasciando spazio a forme di esistenza più efficienti, più potenti, ma meno libere. È forse proprio questa possibilità, mai del tutto eliminabile, a rendere la domanda sull’umano non solo teorica, ma irrevocabilmente pratica.

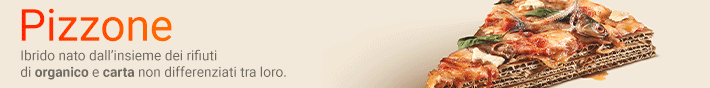






Non ci sono commenti
Partecipa anche tu