La crisi di governo si è avvitata su se stessa e oggi, a sessanta giorni dal voto, un quadro politico già incerto si è fatto più pericoloso di quanto non fosse.
Vero è che da Francoforte il ruolo fondamentale di Mario Draghi concede ai conti italiani un orizzonte di respiro di alcuni mesi: la prosecuzione del quantitative easing, ossia l’acquisto di titoli di debito emessi dal Tesoro italiano, mantiene bassi i tassi di interesse e scongiura almeno a medio termine (almeno sino al termine della presidenza Draghi) il rischio di un’aggressione dei mercati internazionali mediante i metodi sperimentati nel 2011, quando la vorticosa ascesa dello spread costrinse alle dimissioni il governo Berlusconi e indusse Giorgio Napolitano ad affidare a Mario Monti il compito ingrato di agire con la forza là dove le forze politiche non sarebbero potute arrivare (o comunque, non lo avrebbero voluto per il timore di conseguenze elettorali poi comunque in larga misura verificatesi).
Il punto è che il presidio Draghi alla prima poltrona delle Banche centrali europee non durerà in eterno e che gli impegni contenuti negli accordi con i partner europei, a iniziare dal fiscal compact, dovranno essere rispettati nei tempi e nelle dimensioni concordate. L’assenza di un governo in carica e la situazione di stallo che si verrebbe a determinare con nuove elezioni svolte con la medesima legge in vigore che ha prodotto il risultato del 4 marzo scorso riporterebbe sull’Italia i riflettori delle potenze continentali ex extracontinentali, vanificando presumibilmente i timidi segnali di ripresa dell’economia che negli ultimi tre anni sono stati registrati portando il paese al di fuori del rischio di una possibile catastrofe.
Le carte consegnate dai partiti nelle mani di Mattarella sono carte politicamente farlocche. In due mesi non si sono visti quei segnali di responsabilità istituzionale in grado di mettere al primo posto i reali bisogni degli italiani.
I vincitori delle elezioni, Salvini e Di Maio, non hanno neppure avviato un dialogo serio sul merito dei programmi preferendo concentrare la propria azione su forzature che un sistema proporzionale (e i numeri che ne sono scaturiti in Parlamento) non può metabolizzare.
L’inesperienza del capo politico dei 5Stelle si è evidenziata soprattutto nelle mosse repentine e prive di logica messe in atto la scorsa settimana. La pervicacia con cui Di Maio rivendica per se stesso la guida di un eventuale governo ne rivela un’immaturità politica e tattica impressionanti. L’apertura di credito verso il Pd è apparsa frutto di improvvisazione, così come velleitarie appaiono le condizioni poste ai potenziali alleati a sinistra (eliminate Renzi poi parliamo) e a destra (eliminate Berlusconi poi parliamo).
Questa generazione di newcomers premiata nell’Italia meridionale da un consenso vagamente fatalistico restituisce un Movimento 5 Stelle assai diverso da quello delle origini, tutto concentrato sull’occupazione di ogni spazio parlamentare, enormemente disinvolto nella cosiddetta “apertura di forni”. Ciò per paradosso ha aiutato Salvini a rafforzare la propria leadership in un’area di centrodestra populista già profondamente radicata nelle zone più forti del paese, ossia tutto il Nord Emilia inclusa, e a svelare la debolezza territoriale dei grillini (o, se vogliamo, post-grillini) che si evidenzia regolarmente nelle elezioni locali.
*
Ma se una destra c’è in Italia, come in tutta Europa, e gode di una brillante relazione con il proprio elettorato perché considerata credibile sui temi-chiave (fisco, sicurezza, immigrazione), è invece la sinistra a mancare.
Le cose nel Pd e alla sua sinistra stanno addirittura peggio di quanto il disastroso passaggio elettorale abbia certificato. Ogni giorno osserviamo lo sgretolamento di un ceto dirigente cui venne consegnata in dote l’eredità del riformismo italiano o di una larga parte di esso in una continua congerie di personalismi, guerre intestine, lotte per il potere – a cui fa da contraltare smisurato l’assenza di una visione politica minima, di un orizzonte strategico, persino di agganci ideali vicini o lontani cui l’elettorato di sinistra è storicamente abituato a guardare e a trarre spunto. Vero è che il socialismo democratico è in crisi ovunque, ma qui in Italia non possiamo certo considerare il Pd un partito che abbia molto in comune con la socialdemocrazia, classica o moderna. La lotta feroce tra renziani e non renziani sta corrodendo il partito dall’interno: ma è una lotta per il potere, non per gli ideali. E quando si perdono gli ideali, quantomeno come orizzonte di fondo per convincere il cittadino-elettore a darti fiducia, ogni comunità è destinata a fallire.
Scrivemmo nella notte del 4 marzo di una traversata del deserto che avrebbe atteso la sinistra italiana. La realtà afferma l’esatto contrario: qui stanno tutti a preoccuparsi di non perdere il seggio in Parlamento, altro che traversate.
Nel delirio ipertatticista di questi giorni nel Pd riescono a litigare perfino se sia il caso o meno di partecipare al forno di Di Maio – ossia a una forza politica che sino al giorno prima ha basato la propria strategia sulla criminalizzazione indistinta non solo di Renzi, ma perfino di Luca Vecchi e signora a Reggio Emilia.
Meno male che Draghi c’è, abbiamo scritto, e per il resto attendiamoci che Mattarella voglia e riesca quantomeno a dare un governo a questa incorreggibile repubblica capace di mettere al riparo i conti pubblici e a scrivere finalmente una legge elettorale capace di stabilire vincitori e vinti in tempi rapidi. Nel contempo, c’è da augurarsi che gli italiani non perdano definitivamente quel poco di senso civico consegnato loro nella seconda metà del Novecento sciaguratamente dissipato a partire dalla caduta e sempre più rimpianta Prima Repubblica. In Friuli Venezia Giulia, regione di confine e gente seria, più della metà degli aventi diritto ha scelto di non votare. La disaffezione, per il compimento della democrazia, è sempre un pessimo segnale.



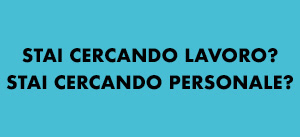


Ultimi commenti
Visto come sta andando a Gaza, la Nato potrebbe considerare il lancio di due bombe nucleari tattiche su teheran da parte israeliana una reazione
Trascrivo questa ricerca in ricordo del Beato Rolando Rivi: L’uccisione del seminarista ROLANDO RIVI (di anni 14), a Castellarano (RE) il 13 aprile 1945. • Il 10 aprile […]
Forse un candidato ... dovrebbe lasciare qualche incarico ... nell'ordine....