La notizia che lunedì 26 febbraio la squadra mobile di Reggio Emilia ha arrestato Salvatore Turrà ci riporta alle indagini di Aemilia in attesa del 6 marzo, quando riprenderanno le udienze per il rush finale.

Salvatore è tornato dietro le sbarre per violazione delle norme sulle misure di prevenzione e porto abusivo d’armi; dovrà ora scontare un anno di reclusione. Si tratta di un personaggio relativamente di secondo piano, non imputato in questo processo, che ha dei precedenti per estorsione ed era finito nel lunghissimo processo Edilpiovra come parte offesa per un furto subito dagli amici/nemici della famiglia Amato.
Ben più importante di lui, dal punto di vista ‘ndranghetistico, appare il fratello Roberto, che a 42 anni è stato condannato a nove anni e sei mesi di carcere più due di libertà vigilata nel rito abbreviato di Aemilia. Pena confermata in appello per l’appartenenza alla cosca Grande Aracri, anche se Roberto è stato assolto da uno dei reati ipotizzati: quello di tentata estorsione ai danni di Luigi Muto, al quale secondo i pm aveva bruciato l’auto nel maggio 2012 per convincerlo a prestargli 50mila euro.
Anche con i Muto la famiglia dei Turrà andava d’accordo un giorno sì e cinque no. Racconta il collaboratore di giustizia Salvatore Muto che, quando lui era piccolo giù a Cutro, aveva uno zio direttore di banca, Santino Muto, finito nei guai perché aveva aiutato gli autori di un sequestro a depositare sul conto corrente il contante del riscatto.
A questo zio Nicolino Sarcone aveva portato degli assegni che lui si era rifiutato di cambiare, e così Nicolino “ha mandato Roberto Turrà a mettergli una bomba sulla macchina. Che tra l’altro Roberto è mio cugino, e per questo sappiamo tutto, perché è una cosa fatta in casa, diciamo”.
Intervennero poi i Dragone a riportare la pace. Da notare che Salvatore Muto colloca questo fatto quando lui era piccolo: “Avrò avuto dieci, undici anni”, e siccome il pentito è del 1977, due anni più giovane di Roberto Turrà, significa che il cugino ne aveva al massimo tredici, l’età giusta per iniziare a far saltare in aria le auto con le bombe.
E dire che i Turrà avevano solo da ringraziarli, i Muto, perché dopo l’omicidio del padre in Calabria da parte di un muratore che di cognome faceva Galdì, i tre fratelli Roberto, Salvatore e Giuseppe furono allevati dal padre di Salvatore Muto, che “gli faceva da padre, gli andava a fare la spesa, li portava a scuola”.
Giuseppe è il più vecchio dei tre e non risultava invischiato in storie di mafia. L’imperfetto è d’obbligo per la risposta che Salvatore Muto dà al pm Mescolini nell’interrogatorio del 2 ottobre 2017.
Mescolini: “Anche Giuseppe è sempre stato in ambito criminale?”
Muto: “Sì, sì, sì, perché ne ha combinate pure”
Tra le cose che ha combinato Giuseppe, e che non si fanno in una famiglia come quella di ‘ndrangheta, è aver concesso un prestito a tasso usuraio a un proprio cugino che è anche fratello di Salvatore Muto, braccio destro del capo Francesco Lamanna, a sua volta cugino dello stesso Giuseppe. Muto si arrabbia e se la prende con Giuseppe, che però non molla e vuole i soldi. Allora Salvatore si inventa di incendiare il negozio del proprio fratello giù a Cutro senza dire niente a nessuno, fingendo un atto doloso di intimidazione, per fargli avere i soldi dall’assicurazione e saldare così il debito usuraio.
Il problema è che l’immobile in cui va a fuoco il negozio è di proprietà di Francesco Sarcone, cugino di Nicolino, che ci vive sopra il negozio e si arrabbia di brutto: “Chi si è permesso di dare fuoco a un negozio dei Sarcone? Una famiglia protetta”.
Nicolino Sarcone è il capo a Reggio Emilia e non ci sta: porta addirittura la questione in casa di Nicolino Grande Aracri e partono le indagini della criminal pol che ben presto arrivano a Salvatore Muto. Il quale, messo alle strette, prima si confessa con Lamanna, poi è costretto a scendere con lui a Cutro nel 2011 per raccontare tutta la verità a Grande Aracri.
Ma Salvatore Muto, ben imbeccato dal suo capo che gli consiglia di dire tutta la verità, è un uomo sincero che sa essere convincente, come si è visto in aula durante la sua deposizione. Spiega per filo e per segno a casa del boss come sono andate le cose e riporta al procuratore Mescolini cosa gli rispose Nicolino Grande Aracri: “Salvatò, sappiamo che sei stato tu e va bene. Ma se io trovavo che c’era stata un’altra persona che aveva fatto una roba del genere, io lo dovevo ammazzare, lo sai?”.
Il grande capo però sa già dove vuole arrivare: perdona Salvatore Muto e decide che la colpa originale è di chi ha tentato l’usura ai danni di un membro della famiglia Muto di Cremona e Piacenza. È come farla a Lamanna, e farla a Lamanna è come farla allo stesso Grande Aracri. E allora la sentenza finale è che bisogna far fuori tutti e tre i fratelli Turrà, così si risolve il problema.
A cominciare dalla vera testa calda che non è Giuseppe ma Roberto, quello che per Grande Aracri è responsabile della morte del muratore Galdì, la cui moglie incensurata era andata a chiedere vendetta al boss.
È il Turrà sempre ben armato che, secondo Valerio, tiene nascosti in un garage sotto casa un kalashnikov, un moschetto e un fucile, più due pistole calibro 38, una a canna lunga e una a canna corta: “Ma non nel garage di sua proprietà, dove sono andate tante volte le forze dell’ordine a cercargliele nel posto sbagliato”, dice Valerio ai pm Ronchi e Mescolini nel giugno dello scorso anno: “In uno di fianco. Che se magari ci andavano con i cani glieli trovavano”.
Della prematura fine di Roberto Turrà viene incaricato lo stesso Antonio Valerio, sebbene sia imparentato con un Turrà che ha sposato Palmina, la sorella di suo padre. A uccidere Salvatore Turrà, quello arrestato dalla squadra mobile, dovevano essere nientemeno che i fratelli Sarcone. A liquidare il più anziano dei tre fratelli, Giuseppe, ci dovevano pensare invece giù a Cutro. Per la cronaca nessuno dei tre ad oggi è morto.
Uccidere Roberto, spiega Valerio nei suoi interrogatori, non era semplice perché l’uomo è furbo e quando i due erano soli il suo cellulare stava sempre acceso e lui diceva a tutti dove si trovava e con chi: costruirsi un alibi era impossibile.
Oppure, altra spiegazione, quella del killer è una professione seria e non tutti ci riescono. Tanto che Valerio, Lamanna e Salvatore Muto rispolverano “Delitto per delitto”, il vecchio film di Hitcchock del 1951, e si affidano alla grande sceneggiatura di Raymond Chandler per realizzare un doppio omicidio incrociato.
C’è un uomo da ammazzare a Mantova che interessa la cosca d’oltre Po, un omicidio facile facile in un parco dove quell’uomo va sempre a correre. Ci penserà Valerio, che neppure lo conosce. Mentre a Reggio, per finire il lavoro con Roberto Turrà, verrà dalla Lombardia Pino Lo Prete, che qui nessuno conosce. Uno scambio di favori e due alibi perfetti.
Ma i film arrivano sempre alla fine, la realtà a volte no. Per fortuna di Roberto Turrà, che intanto mentre gli altri tramano non riesce a stare fermo e brucia a Reggio Emilia l’auto di Luigi Muto, cugino di Salvatore, perché non potendosela prendere con l’uomo di Lamanna – protetto da Grande Aracri – deve pur trovare qualcuno su cui sfogarsi.
È davvero così difficile uccidere Roberto e i suoi fratelli? Forse. O forse la spiegazione è più venale e Valerio la lascia intendere in una lunga riflessione davanti ai due pm, al maresciallo D’Agostino e al brigadiere Colapietro il 19 luglio 2017.
A volere quegli omicidi erano i due Nicolino, Grande Aracri e Sarcone, ma anche Alfonso Diletto che a Valerio chiedeva: “Ma si fa o non si fa? Parate o non parate?”.
E il boxeur della Pugilistica Reggiana, l’uomo di ‘ndrangheta a statuto speciale, il mafioso 5.0 che teneva i piedi in tre staffe ed è uscito indenne da mille imboscate di amici/nemici e parenti/serpenti, spiega che si può essere astuti quanto si vuole ma prima o poi un errore in un mese lo si commette.
Uccidere Roberto Turrà non è un problema, basta mettersi alle sue calcagna senza altri pensieri per la testa e aspettare l’errore che prima o poi arriva. Dice Valerio: “Ma io devo pure avere attenzione alle mie cose, io devo andare a guadagnarmi da lavorare. E se io devo lasciare da parte le mie cose per farmi le tue, tu devi mettermi nella condizione di poterlo fare e io lo faccio. In un mese stai tranquillo che io te lo faccio, così come sono state fatte le altre cose. Mettimi nella condizione di poterlo fare: metti 50.000 euro sul tavolo e vedi che le cose si fanno. È tipo un mercenario; però capisci che io devo avere tranquilla la testa per potermi dedicare a quella persona”.
Su Roberto Turrà che doveva essere ucciso da Antonio Valerio, dopo che gli stessi mandanti avevano dato ordine a Roberto Turrà di uccidere il primo collaboratore di giustizia della cosca, Angelo Salvatore Cortese, sono scritti nei verbali di Aemilia i capitoli di un romanzo noir senza fine.
Ma secondo la mente economica della cosca Giuseppe Giglio, che possiede 1008 conti bancari registrati nell’anno in cui risulta nullatenente dalla dichiarazione dei redditi, gli uomini si misurano a soldi e non con i capitoli dei romanzi: “Roberto Turrà era una persona che faceva uso di cocaina. A volte riuscivamo a gestirlo e a volte no. Lui per pochi centesimi di euro se doveva mettere fuoco a qualcosa, cioè, ci andava. Cioè, a minacciare qualcuno, ci andava”.
Roberto Turrà per pochi centesimi ci andava. Antonio Valerio per 50mila euro.
Poi c’è il colpo di scena finale:
Pm Mescolini: “Azioni contro di lei, Valerio, se n’è mai accorto che qualcuno le dovesse fare?”
Antonio Valerio: “Sì, come no! Il Turrà che me la doveva fare anche a me. Questa ancora non ve l’ho detta! Perché non siamo arrivati al fatto di Jimmy il milanese, che con i Casalesi e con…”
Pm Beatrice Ronchi: “Adesso è troppo!”
Pm Marco Mescolini: “Non incominciamo adesso una storia così”
Pm Beatrice Ronchi: “Sono le 18.28: dopo la rilettura viene chiuso il verbale. Spegniamo l’interrogatorio e abbiamo finito”.
(da "I fratelli Turrà e il delitto per delitto" – Cgil Reggio Emilia)
* * *
La Cgil di Reggio ha scelto una forma intelligente per seguire il processo Aemilia affidando a uno dei giornalisti più esperti della realtà locale, che è anche autore consolidato di opere di narrativa, lo sviluppo del dibattimento che va svolgendosi in questi mesi a Reggio Emilia. 24Emilia e io personalmente siamo particolarmente grati a Paolo e alla Cgil per averci concesso l’utilizzo dei suoi testi, anche nella consapevolezza che ciò possa contribuire a rendere più capillare la diffusione delle vicende legate alla penetrazione della ‘ndrangheta nella nostra provincia e a far sì che da una maggiore consapevolezza possano scaturire gli anticorpi affinché questi germi di malaffare possano essere definitivamente estirpati dal territorio emiliano. (n.f.)

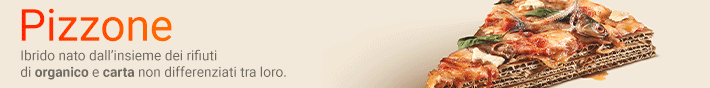




Ultimi commenti
I templari c'erano eccome , ho trovato una moneta a Pomponesco E a Pomponesco c'era una zecca
che forza i reggiani! inarrestabili e inamovibili, brontolano per 5 anni e poi via testa bassa e pedalare! certo che il primo che dice qualcosa
Elezioni Europee, Elezioni Regionali, si fanno nomi, posti, e altro senza però parlare di programmi, quelli sono irrilevanti e fumosi, i soldi mancano per ogni […]